
Azzardo e modernismo: come surrealisti e dadaisti rappresentavano il caso e il gioco
All’inizio del XX secolo, l’emergere del surrealismo e del dadaismo segnò una rottura radicale con le forme tradizionali di espressione artistica. Entrambi i movimenti ruotavano attorno all’idea di liberarsi dal controllo razionale, abbracciando la casualità e cercando significati più profondi nel caso. Centrale nella loro estetica e filosofia era la nozione di gioco—gioco del subconscio, del linguaggio e dei materiali. Artisti come Marcel Duchamp, Max Ernst e André Breton esplorarono questi temi in modi innovativi, tracciando paralleli diretti tra il processo artistico e giochi come gli scacchi, il poker e la roulette. Questo articolo analizza come il loro lavoro rifletta tali idee, rivelando il significato filosofico del caso nell’arte modernista.
Giochi della mente: gli scacchi di Marcel Duchamp
L’ossessione di Marcel Duchamp per gli scacchi non era solo un passatempo personale—era una ricerca artistica e intellettuale che rifletteva la sua filosofia sul caso e il controllo. Duchamp, figura chiave di entrambi i movimenti, usava spesso il gioco come metafora della vita, della creatività e del pensiero. Diversamente dai giochi di pura fortuna, gli scacchi sono un sistema strutturato, ma Duchamp lo infuse di imprevedibilità collegandolo all’arte. La sua opera del 1917 “Portrait of Chess Players” e l’installazione “Pocket Chess Set” colmavano il divario tra gioco e opera d’arte, trattando l’interazione strategica come una forma performativa di creazione.
L’abbandono dell’arte convenzionale da parte di Duchamp per dedicarsi agli scacchi fu simbolico. Per lui, il gioco rappresentava una forma di pensiero più elevata—astratta, pura e incontaminata dal mercato artistico o dalle opinioni critiche. Anche il suo famoso ready-made “3 Standard Stoppages” (1913–14), dove lasciava cadere fili da un’altezza per conservare le loro curve casuali, rifletteva questa stessa fascinazione per le regole sovvertite dal caso.
Nella visione di Duchamp, la casualità non era una fuga dalla forma ma un nuovo modo di definirla. Gli scacchi diventavano una tela logica dove il disordine poteva acquisire legittimità.
Il caso come mezzo artistico nella pratica di Duchamp
“3 Standard Stoppages” resta una delle dimostrazioni più eloquenti di come Duchamp incorporò la casualità nel suo metodo artistico. Lasciando che i fili cadessero liberamente e conservandone le forme, ruppe con i sistemi di misura tradizionali. Dichiarò che fosse “uno scherzo sul metro”, ma metteva in discussione la verità oggettiva nella rappresentazione visiva.
Questo gesto—semplice nell’azione ma radicale nel significato—trasformava movimenti arbitrari in linee sacre. Preservandole, Duchamp elevava il caso a legge estetica. Dimostrava che anche la casualità, se riconosciuta e replicata, assume una struttura narrativa.
Il suo lavoro trasformò così la “fortuna” in metodo creativo. Il caso non era più uno sfondo passivo, ma un elemento centrale del processo concettuale.
Automatismo visivo e gioco nei collage di Max Ernst
Max Ernst, figura chiave del surrealismo e del dadaismo, introdusse i giochi del caso attraverso tecniche come collage, frottage e decalcomania. Questi metodi miravano a eludere l’intenzionalità cosciente e abbracciare l’imprevisto. Il collage, in particolare, funzionava come una partita di carte: immagini tagliate, mescolate e ricomposte per generare narrazioni imprevedibili.
I collage di Ernst degli anni ’20 come *Une semaine de bonté* (“Una settimana di bontà”) creavano giustapposizioni assurde in contesti formali, simili a una carta jolly inserita in un mazzo ordinato. La casualità, tuttavia, non era priva di significato. Metteva in discussione l’iconografia tradizionale e creava nuovi codici visivi basati sull’associazione spontanea.
Per Ernst, i giochi erano non solo metafore ma meccanismi. Il frottage (sfregare la matita su superfici ruvide) ricordava il lancio di dadi o il giro della roulette—azioni in cui il controllo veniva affidato all’ambiente. Da queste impressioni nascevano forme che Ernst interpretava e sviluppava, rendendo l’inconscio un collaboratore.
Il ruolo dell’irrazionale nelle tecniche di Ernst
I metodi visivi di Ernst formalizzavano l’irrazionale. Pur sembrando casuali, erano rituali per generare significato attraverso percorsi indiretti. Frottage e collage imitavano sistemi casuali, ma Ernst li collocava deliberatamente in un contesto compositivo. C’era una tensione tra caos e ordine, simile a quella nei giochi d’azzardo.
Questa ambiguità consentiva a Ernst di esplorare il subconscio, principio cardine del surrealismo. Come una roulette che gira oltre il controllo del giocatore, così i suoi materiali si evolvono al di là della conoscenza preventiva dell’artista. Tuttavia, lui ne rimaneva interprete—ordinava il caso in dichiarazioni coerenti.
Le opere di Ernst sfidavano il mito del genio artistico come puro controllo. Proponendo una genialità che accetta di perdere per trovare qualcosa di autentico, Ernst abbracciava l’irrazionale come verità.
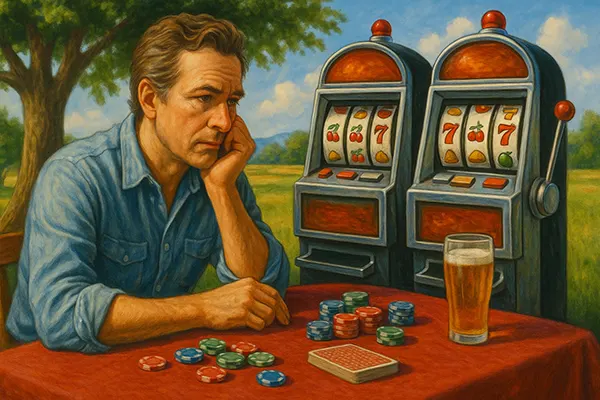
André Breton e la poetica del gioco di carte
André Breton, fondatore del surrealismo, portò una dimensione letteraria e psicologica al concetto di gioco e caso. Affascinato dai tarocchi, li vedeva non come strumento divinatorio ma come meccanismo poetico per accedere all’inconscio. Le sue opere, come *Nadja* e *L’Amour fou*, mescolano narrazione e logica onirica.
Nel “Manifesto del Surrealismo” (1924), Breton affermava che l’automatismo psichico puro fosse la via all’espressione autentica. Per ottenerla, bisognava eliminare l’intenzione—come nel mescolare carte o far girare la roulette. Per Breton, questi gesti rompevano la razionalità e favorivano la rivelazione.
Negli anni ’30, le riunioni surrealiste includevano giochi inventati come il “cadavere squisito” o le charade simboliche. Non erano solo passatempo, ma rituali collettivi per riscrivere la percezione e permettere al subconscio di parlare. Il gioco, per Breton, era trasformativo e necessario.
Simbolismo e semiotica nei giochi surrealisti
Per Breton, le carte rappresentavano l’interazione tra destino e volontà personale. Ogni carta pescata era uno stimolo per il linguaggio, l’emozione o l’azione. Il processo di lettura era sia performance che riflessione.
Questo concetto si allinea alla semiotica nell’arte moderna, dove i segni non hanno significati fissi. Come il jolly che cambia il corso del gioco, i simboli surrealisti mutano secondo contesto e intuizione. I giochi permettevano tali mutazioni, rendendoli strumenti ideali per l’esplorazione poetica.
La fedeltà di Breton alla casualità era un rifiuto della logica autoritaria. Sostenendo i giochi come strumenti creativi, proponeva una nuova forma di conoscenza—esperienziale, frammentaria ed emotiva. Era un apprendimento dove perdere il controllo era l’obiettivo.
